 Interventi
Interventi
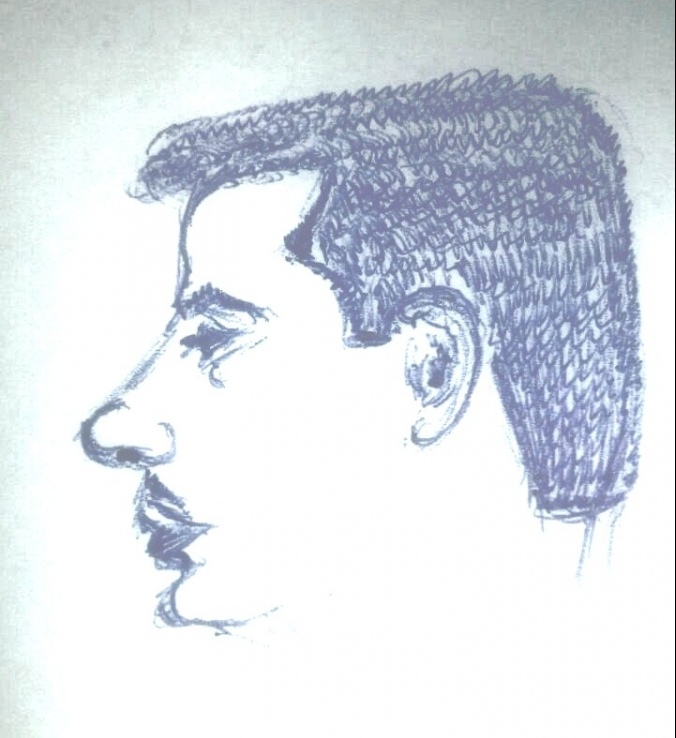
di Redazione online
Riceviamo e pubblichiamo il seguente contributo:
Intermissus: versione laica della sospensione a divinis?
Abstract
Esplorando il parallelo tra la sospensione a divinis e la figura dell’intermissus, si delineano somiglianze e divergenze tra sanzione religiosa e neutralizzazione laica: un fenomeno che parla di relazioni, appartenenza e confini morali della convivenza collettiva.
Intermissus: versione laica della sospensione a divinis? di Barbara Santucci
La sospensione a divinis, nella sua accezione canonica, priva un chierico dell’esercizio pubblico delle sue funzioni sacre, mantenendone tuttavia l’ordinazione e la dignità sacramentale. Non è un'espulsione né una scomunica, ma una misura cautelare o correttiva. Un atto di sospensione dall'agire, non dall’essere. E, proprio per questo, in molte organizzazioni laiche o parareligiose, la sua eco sembra riecheggiare in altre forme, più sfumate ma altrettanto incisive: una di queste è la figura dell’intermissus.
In recenti riflessioni sociologiche e giuridiche (si veda il contributo di Antonio Rossello apparso su Pagina Tre, L’intermissus: l’inclusione apparente come risposta all’incompatibilità relazionale), è stato tematizzato questo particolare statuto operativo, che si configura come un’esclusione implicita, non formalizzata, ma socialmente evidente. L’intermissus è colui che, pur non essendo espulso da un’organizzazione, viene neutralizzato nella sua capacità di incidere, in una forma di sospensione tacita che riecheggia, seppur in modalità laica, l’antico istituto canonico.
La sospensione a divinis: una cornice teologica e disciplinare
Nel diritto canonico, la sospensione a divinis si configura come una pena medicinale, volta a ricondurre alla disciplina ecclesiastica il chierico colpevole di atti contrari ai doveri del proprio stato. È disciplinata dai canoni 1333-1334 del Codice di Diritto Canonico e può riguardare il divieto di celebrare la messa, di amministrare i sacramenti, o di esercitare incarichi ecclesiastici. La sua natura è progressiva, proporzionata, e sempre finalizzata alla riconciliazione, non alla punizione pura.
Essa non intacca l’essere sacerdote, ma ne sospende l’agire pubblico. In questo senso, essa presuppone la distinzione tra identità e funzione, tra appartenenza ontologica e operatività concreta. Un principio che ritroviamo, sotto altre forme, anche nella configurazione dell’intermissus.
Laicità e sospensione relazionale: l’intermissus
In ambito associativo, laico o para-istituzionale, l’intermissus emerge quando il soggetto si mostra incompatibile con le dinamiche collettive, pur non venendo meno ai requisiti formali dell’appartenenza. È un caso in cui la coesione del gruppo viene tutelata non con l’espulsione, ma con la riduzione silenziosa della partecipazione effettiva.
A differenza della sospensione a divinis, qui non interviene un'autorità superiore con una dichiarazione formale. L’operazione è comunitaria, diffusa, spesso inconsapevole. L’intermissus resta titolato, presente, menzionato nei verbali, ma nessuno più gli assegna compiti. Le sue opinioni non incidono, la sua presenza non determina. Egli è incluso nel perimetro formale, ma escluso dal campo semantico.
Diritto muto e tolleranza funzionale
Se nel diritto canonico la sospensione è dichiarata e motivata, nell’intermississus la norma si fa silenziosa. Parliamo di diritto muto, ovvero di una regolazione senza sanzione: gli statuti permettono di tollerare il soggetto senza investire l’organizzazione in un conflitto espulsivo. È un uso selettivo delle norme, ispirato più a una logica di difesa armonica che a un rigorismo giuridico.
In questo senso, il parallelo con la sospensione a divinis si fa più stringente: in entrambi i casi l'identità è salvata, la funzione è congelata, l'onore è rispettato, ma l'efficacia operativa è sospesa. Si tratta di due strategie per disattivare il potenziale disturbante, mantenendo l'integrità del sistema e la dignità del soggetto.
Etica dell’evaporazione: né conflitto né rifiuto
Ma se la sospensione a divinis è un atto giuridico, quella dell’intermissus è una fenomenologia sociale. Si basa su un'etica dell'evaporazione, che evita lo scontro frontale per tutelare la convivenza. È una forma laica di misericordia organizzativa, che non espelle il soggetto eccentrico, ma lo assorbe in un’area neutra, dove l’inefficacia si consuma da sola.
La sospensione a divinis vuole correggere, l’intermissus vuole contenere. La prima si esercita con autorità, la seconda con tolleranza. Ma entrambe rispondono al medesimo principio di fondo: proteggere l’organizzazione dal disordine, senza recidere l’appartenenza.
Conclusione: un archetipo comune?
L’intermissus, allora, può essere visto come una versione secolarizzata della sospensione a divinis. Non ne condivide l’intenzione correttiva, ma ne riproduce la struttura relazionale: mantenere la forma, sospendere la funzione. In entrambi i casi, si cerca una soluzione non traumatica a un’incompatibilità relazionale.
Questa analogia ci invita a riflettere sul valore sistemico della sospensione: non come punizione, ma come regolazione gentile dei limiti dell’inclusione. Un’arte antica, che attraversa i secoli e le istituzioni, e che ci ricorda che talvolta, per salvare una comunità, è più utile tacere che condannare.
Bibliografia essenziale
Codice di Diritto Canonico, canoni 1333-1334.
Luhmann, N. , Sistemi sociali, Il Mulino, Bologna, 1990.
Douglas, M. , Purezza e pericolo, Il Mulino, Bologna, 1995.
Donati, P. , La sociologia relazionale, FrancoAngeli, Milano, 2001.
Sartori, G. , Teoria della democrazia, Il Mulino, Bologna, 1987.
Sitografia
Pagina Tre, L’intermissus: l’inclusione apparente come risposta all’incompatibilità relazionale, https://paginatre.it/lintermissus-linclusione-apparente-come-risposta-allincompatibilita-relazionale/
Vatican.va, Codex Iuris Canonici, https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_it.html
Treccani.it, voce sospensione a divinis, https://www.treccani.it
Barbara Santucci è una libera pensatrice e studiosa indipendente dei fenomeni relazionali nelle strutture sociali e simboliche. Appassionata della materia e animata da uno sguardo interdisciplinare, esplora le zone grigie tra appartenenza e alterità, tra forma e funzione, con particolare attenzione agli equilibri silenziosi che regolano la convivenza nei contesti associativi, religiosi e civili. La sua scrittura coniuga rigore analitico e sensibilità umana, offrendo chiavi di lettura originali sui nodi invisibili del vivere collettivo.
Venerdì 25 luglio 2025
© Riproduzione riservata
303 visualizzazioni